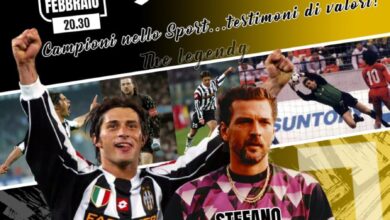Venerdì scorso sono stato alla celebrazione del 25 aprile proposta dall’Amministrazione comunale: prima nella piazza dietro al comune, per omaggiare le vittime civili del bombardamento del 29 febbraio 1944, e poi davanti al villino Franchi dove nel 1943 dimorò, in confino politico, Renato Vuillermin, fulgida figura di democratico cristiano antifascista fucilato dai repubblichini nel dicembre 1943.
C’erano il vice sindaco, il presidente del consiglio, alcuni assessori e consiglieri di maggioranza. Assente la minoranza che ha preferito fare una sua celebrazione e si è compiaciuta che in tale circostanza tutta la sinistra sia stata unita. D’altronde negli ultimi anni è stato sempre così: la sinistra non ha mai partecipato alle celebrazioni del 25 aprile e neanche a quelle della “Giornata della memoria” proposte dall’Amministrazione comunale. Eppure sono state manifestazioni di grande spessore che hanno inteso riproporre alla memoria collettiva: il sacrificio, poco conosciuto, delle centinaia di migliaia di soldati italiani che pur di non aderire alla RSI scelsero la dura prigionia nei campi tedeschi; il passaggio a Giulianova del II Corpo d’armata polacco; la testimonianza del prof. Antonio Parisella, per tanti anni direttore del Museo Storico della Liberazione di via Tasso; l’apposizione di pietre d’inciampo per ricordare i giuliesi caduti ed internati.
Momenti che hanno inteso celebrare l’alba della nuova Italia dopo la barbarie della guerra e del nazi-fascismo ricordando chi ha pagato di persona la scelta per la libertà. Ne so qualcosa perché quando ero direttore dell’Archivio di Stato ho collaborato con l’ottimo Walter De Berardinis nella ricerca archivistico-documentaria su varie figure di militari giuliesi. Come studioso di storia ritengo che disertare le celebrazioni istituzionali a prescindere dal contenuto proposto, sia contradittorio rispetto al vero senso del 25 aprile che non può essere rivendicato solo da una parte. La Resistenza fu un movimento composito che traeva origine dal diffuso mutamento della coscienza civile che si era verificato nella società italiana dopo la drammatica esperienza della guerra. Tale dinamica è ben documentata dalla esperienza di due giovani teramani trasformati dall’impatto con i fatti bellici: Renato Molinari, dirigente provinciale del Guf teramano, poi partigiano morto fucilato e il “nostro” Venanzo Crocetti, ritenuto giovane artista prodotto della rivoluzione, che passerà il resto della vita ad esporre il Giovane cavaliere della pace.
D’altronde i mutamenti istituzionali sono possibili solo se condivisi da maggioranze che hanno maturato nuove convinzioni. È vero che il fascismo fu una dittatura, ma ebbe largo consenso nella popolazione. In Italia i primi resistenti furono i soldati che rifiutarono di arrendersi ai tedeschi, gli ufficiali monarchici che davanti ai plotoni di esecuzione gridarono “Viva l’Italia!”. A Teramo un gruppo di soldati e ufficiali del battaglione di artiglieria semovente guidati dal capitano Giovanni Lorenzini, che sarà il primo prefetto dopo la liberazione nominato dal CLN, rifiutò di arrendersi ai tedeschi portando armi e pezzi di artiglieria a Bosco Martese.
IL 25 APRILE È PATRIMONIO DELLA NAZIONE, appropriarsene è una falsità storica (oltre a una manifestazione di settarismo politicamente controproducente, ma questo è un altro discorso).
Ottavio Di Stanislao