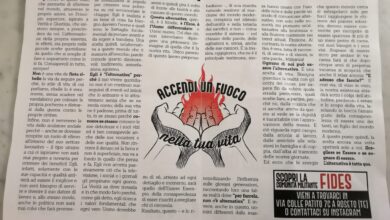Teramo. Sui numeri della domanda di prestazioni, alla Asl di Teramo, e di riflesso sulle liste di attesa, prende una posizione il Comitato civico per la tutela dell’ospedale Val Vibrata e della sanità pubblica.
L’intervento
La ASL parla di numeri shock: un incremento della domanda di prestazioni sanitarie del 323%, a fronte di un aumento dell’offerta pubblica del 16%. Dati che, di fatto, sembrano sancire una resa annunciata, una sorta di bandiera bianca issata di fronte all’esplosione della domanda. Ma davvero non si può fare nulla?
Secondo la ASL, la soluzione passa attraverso una stretta sulle prescrizioni inappropriate, in larga parte attribuite ai medici di base. Ma è davvero questa la causa principale? Il Comitato Civico per la Difesa dell’Ospedale Val Vibrata e della Sanità Pubblica propone una lettura più ampia e articolata del fenomeno, che merita attenzione.
In economia sanitaria si parla da tempo di “domanda indotta dall’offerta”: quando l’aumento delle prestazioni disponibili — esami, visite, interventi — genera una richiesta crescente, non sempre giustificata da reali bisogni clinici. Il problema non è solo l’aumento dell’offerta pubblica (+16%, come da comunicato ASL), ma soprattutto la proliferazione delle strutture ambulatoriali private, che in molte aree del territorio stanno crescendo senza sosta.
Questo porta con sé un rischio serio: l’introduzione, anche nel nostro sistema sanitario, di logiche di mercato. La conseguenza? Una società sempre più medicalizzata, dove passa il messaggio che “più prestazioni equivalgono a più salute”, quando in realtà l’eccesso di diagnostica può generare ansia, falsi positivi, overdiagnosi e persino danni clinici.
Una cosa è certa: l’eccessiva offerta sanitaria privata, soprattutto nel settore diagnostico, può alimentare una domanda non necessaria, che finisce inevitabilmente per ripercuotersi anche sulle liste d’attesa del pubblico.
Certo, non si può intervenire direttamente sulla libera impresa, né impedire l’apertura di nuovi centri privati.
Ma qualcosa si può e si deve fare, soprattutto sul fronte della commistione tra pubblico e privato, che è oggi uno dei principali fattori distorsivi del sistema.
Un esempio: la libera professione svolta da medici ospedalieri — inclusi direttori di struttura complessa — all’interno di centri privati.
È legale, certo!
Ma è anche eticamente sostenibile? Lo è quando produce percorsi privilegiati, per cui il cittadino si vede spesso “obbligato” a rivolgersi prima al privato, per poter poi accedere più facilmente al pubblico?
Un sistema che mina la fiducia e la trasparenza, oltre ad essere ingiusto e discriminante, a danno dei cittadini meno abbienti.
C’è poi un altro fenomeno diffuso: convenzioni tra la ASL e ambulatori privati, con quest’ultimi che erogano prestazioni a cura di medici con contratto esclusivo nel pubblico.
In teoria, queste convenzioni dovrebbero aiutare a ridurre le liste d’attesa. In pratica, spesso accade l’opposto: perché serve ad alimentare una maggiore offerta, in questo caso nel privato, che come dimostrato in numerose analisi di economia sanitaria e come si diceva sopra, genera più domanda. E il problema non si risolve, si cronicizza.
Con l’ausilio del pubblico, che ne esce esso stesso danneggiato.
L’integrazione pubblico-privato, dunque, favorisce una logica di mercato, dove comodità, velocità e scelta del professionista spingono la domanda verso prestazioni spesso non clinicamente essenziali.
Allora, cosa fare? Non certo arrendersi. La regolazione pubblica è essenziale: sia per tutelare l’equità e l’universalismo del sistema sanitario, sia per limitare l’eccessiva espansione dell’offerta privata, laddove genera effetti perversi. Serve una governance regionale e aziendale più consapevole, capace di orientare il sistema verso l’appropriatezza, la prevenzione e la trasparenza.
Non si tratta di opporsi ideologicamente al privato. Si tratta di difendere il diritto alla salute come bene pubblico, non come merce soggetta a dinamiche di mercato. E soprattutto, si tratta di non alzare bandiera bianca”.